 «Si sono persi 15 anni a sperimentare terapie risolutive, ma sarebbe stato meglio concentrarsi su come migliorare la vita dei malati di Parkinson». A parlare è il professor Alberto Albanese, neurologo dell’Università Cattolica, da anni uno dei maggiori esperti nella cura del morbo tristemente famoso per alcuni malati molto noti, tra cui papa Wojtyla, Muhammad Ali e Michael J. Fox. Una patologia che colpisce in Italia almeno 200.000 persone e nel mondo oltre 20 milioni di soggetti.
«Si sono persi 15 anni a sperimentare terapie risolutive, ma sarebbe stato meglio concentrarsi su come migliorare la vita dei malati di Parkinson». A parlare è il professor Alberto Albanese, neurologo dell’Università Cattolica, da anni uno dei maggiori esperti nella cura del morbo tristemente famoso per alcuni malati molto noti, tra cui papa Wojtyla, Muhammad Ali e Michael J. Fox. Una patologia che colpisce in Italia almeno 200.000 persone e nel mondo oltre 20 milioni di soggetti.
Abbandonate le velleità degli impianti di cellule staminali, fetali o di origine animale sui pazienti che, oltre a sollevare problemi etici, hanno dimostrato di non funzionare per la cura della malattia se non addirittura di sviluppare sintomi nuovi, la speranza viene oggi dall’impiego di nuove terapie biotecnologiche che possono aiutare i pazienti colpiti dalle forme più instabili di Parkinson. Il neurologo, docente al corso di laurea in Scienze motorie nella facoltà di Scienze della formazione della sede milanese, le ha sperimentate già a partire dal 1986 al Policlinico “A. Gemelli” di Roma e ha proseguito lo studio delle più innovative terapie sintomatiche che, oggi, sono di tre tipi: pacemaker per la neurostimolazione cerebrale, infusione intraduodenale di levodopa e infusione sottocutanea di apomorfina.
Tre terapie che hanno preso piede nel trattamento dei sintomi del Parkinson, ma la cui efficacia non è stata finora adeguatamente comparata. Non per il professor Albanese che, dispone del know-how e della possibilità di impiegare nella stesso ospedale dove opera, il Besta di Milano, tutte e tre le terapie, che possono agevolare le condizioni dei pazienti, soprattutto migliorando la qualità dei movimenti danneggiati dal morbo grazie a una somministrazione continua. Un progetto clinico che richiede una expertise particolare: «È necessario avere già da tempo acquisito queste linee e stabilizzato i pazienti», spiega il neurologo. In pratica si tratta di verificare, a distanza di anni dall’utilizzo, l’efficacia di queste terapie mettendole a confronto. E i risultati saranno presto pubblicati sul Journal of Neurology Neurosurgery & Psychiatry.
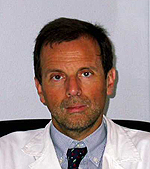 «La comparazione – afferma il professor Albanese (nella foto) – ci dice innanzitutto che l’impiego delle tre biotecnologie funziona bene nel regolarizzare le capacità motorie dei pazienti, ma soprattutto ci indica una gerarchia nella scelta della terapia. La più efficace è l’impianto del pacemaker cerebrale che invia stimoli elettrici al paziente permettendogli di superare i blocchi del movimento. Il neurologo della Cattolica li ha utilizzati nel tempo con almeno 300 malati. Segue l’infusione intraduodenale di levodopa, effettuata con un apparecchio esterno da applicare all’addome. Al terzo posto si colloca l’uso dell’infusione sottocutanea di apomorfina». La prima via non sempre è applicabile per ragioni mediche o neurochirurgiche, come l’impossibilità del paziente di sottoporsi a un intervento chirurgico. E in questo caso scattano le altre due alternative.
«La comparazione – afferma il professor Albanese (nella foto) – ci dice innanzitutto che l’impiego delle tre biotecnologie funziona bene nel regolarizzare le capacità motorie dei pazienti, ma soprattutto ci indica una gerarchia nella scelta della terapia. La più efficace è l’impianto del pacemaker cerebrale che invia stimoli elettrici al paziente permettendogli di superare i blocchi del movimento. Il neurologo della Cattolica li ha utilizzati nel tempo con almeno 300 malati. Segue l’infusione intraduodenale di levodopa, effettuata con un apparecchio esterno da applicare all’addome. Al terzo posto si colloca l’uso dell’infusione sottocutanea di apomorfina». La prima via non sempre è applicabile per ragioni mediche o neurochirurgiche, come l’impossibilità del paziente di sottoporsi a un intervento chirurgico. E in questo caso scattano le altre due alternative.
Gli esiti della comparazione sono importanti per individuare delle linee guida che vengano recepite dalle società neurologiche e dal Servizio sanitario nazionale. Una prassi che permette di definire protocolli terapeutici e di contenere le spese sanitarie. Del resto, se per scegliere le terapie migliori e per impiantarle servono centri di eccellenza, la gestione quotidiana può essere affidata a strutture periferiche sul territorio. Il vantaggio di questo tipo di terapie è la relativa facilità di utilizzo anche da parte dei pazienti o dei familiari. «Ci sono casi di persone che nel sonno tolgono l’apparecchiatura medica e al risveglio sono praticamente bloccati ma, ricollegando il dispositivo, riescono a regolarizzare i propri movimenti», dice il professor Albanese.
Il traguardo di una cura risolutiva è ancora lontano, ma queste nuove strategie sintomatiche migliorano già da ora la vita di questi malati. Un po’ come potrebbe succedere a breve anche per un’altra malattia che colpisce tante persone, l’Alzheimer: «Il traguardo è vicino – afferma Albanese -: sono convinto che tra 5 o 6 anni riusciremo a trovare terapie simili e offrire anche in questo caso una ragionevole speranza».

