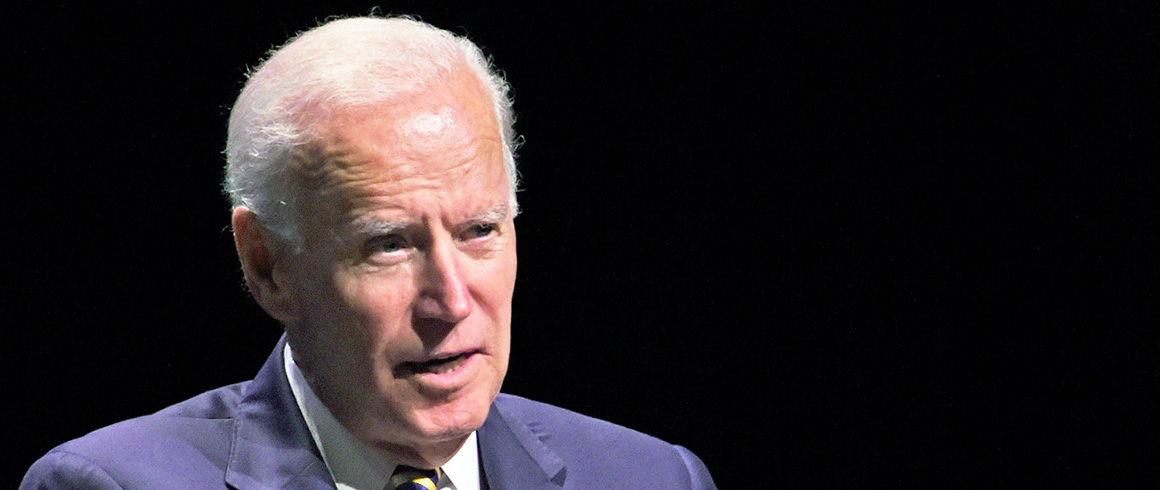Il 3 novembre gli americani sono chiamati al voto per le elezioni presidenziali degli Stati Uniti. Abbiamo chiesto ad alcuni giornalisti di varie testate, particolarmente esperti di politica americana e alcuni dei quali alumni dell’Università Cattolica, di aiutarci a capire dove stanno andando gli Stati Uniti e come affrontano uno dei passaggi più delicati della loro storia. Il nostro speciale
di Giacomo Gitti
Tra poche ore sapremo chi avrà guadagnato la fiducia degli americani. L’esito del voto inciderà sul futuro non solo degli Stati Uniti ma di tutto il mondo occidentale. La campagna elettorale è stata segnata dal tema drammatico della pandemia, che ha finito col mettere in ombra tutti gli altri problemi che segnano la vita degli americani, come spiega Alberto Simoni (nella foto in alto), laureato in Lettere e filosofia in Università Cattolica e caporedattore Esteri del quotidiano “La Stampa”.
«La pandemia ha cambiato i temi e le modalità della campagna elettorale» afferma. «Da un lato Trump ha sfidato le raccomandazioni di prudenza suggerite dagli esperti non curandosi delle precauzioni da osservare durante i comizi in pubblico; dall’altro Biden, più ligio e attento alle norme di prevenzione sanitaria, ha finito col rimanere più defilato. Per queste ragioni è venuto a mancare quello scontro che tradizionalmente negli ultimi due mesi caratterizza le campagne elettorali, privando il dibattito politico di quell’elettricità e di quella tensione vibrante che ne sono sempre stati il tratto distintivo».
Chi ne è stato più penalizzato? «Sicuramente più Trump, grande attore nei comizi rispetto al compassato, e quasi assonnato, Biden. Ci sono stati tre dibattiti anziché quattro, è mancato il pubblico in sala, sono scomparse le contrapposizioni tra i due schieramenti fuori dall’arena e quel pathos che anima sempre i confronti diretti; tutto questo naturalmente ha inciso sulla spettacolarizzazione che ogni campagna porta con sé, perché le elezioni statunitensi sono sì lo strumento per scegliere il presidente del Paese libero più importante del mondo, ma anche un grande show mediatico, una sorta di circo Barnum, che muove persone e quattrini, rappresentando un volano per l’economia».
Davvero una campagna elettorale fa girare l’economia? «Faccio un esempio per spiegarmi: l’Iowa, lo stato che dà il “kick off” alla stagione elettorale, ogni tornata si batte per mantenere questo privilegio e lo fa, non solo per una questione di prestigio, ma per assicurarsi il consistente fiume di denaro che scaturisce dalle decine e decine di visite dei candidati: tra taxi, alberghi prenotati, cene, vendita di gadget il giro d’affari è notevole. Nel 2012, prima dei caucus, Mitt Romney fece registrare addirittura 107 presenze in Iowa».
I due candidati hanno cercato di mettere più in cattiva luce l’avversario, piuttosto che illustrare i punti di un programma… «È stata una campagna elettorale povera di contenuti, priva di grandi idee, con dei toni assolutamente esagerati. Possiamo definirla la “campagna del Covid”, visto che questo macro argomento ha monopolizzato il confronto, facendo passare in secondo piano tutte le altre tematiche. Biden in particolare ha fatto della lotta responsabile alla pandemia il suo cavallo di battaglia e ha cercato di affrontarla in modo sereno, coscienzioso, prendendosi tutte le cautele necessarie ed evitando gli slogan».
Perché si è buttato a capofitto sul Covid? «Perché ha capito che quello era il tallone d’Achille del suo sfidante, non solo per la violenza, l’arroganza, la presunzione con cui ha fronteggiato l’emergenza, ma anche perché la pandemia ha travolto gli Stati Uniti ed è evidente che, se sei il presidente, è tua la responsabilità di mettere in piedi una task force e di dare delle risposte adeguate per proteggere la salute dei cittadini. Biden si è trovato in una situazione di vantaggio, dal momento che l’approccio molto altezzoso e spocchioso del suo avversario non ha portato risultati: i contagi stanno aumentando, l’economia è rallentata, il numero di disoccupati sta crescendo».
E sui programmi, che cosa hanno proposto i due sfidanti? «Essendo tutti i temi della campagna “Covid related”, sappiamo poco o nulla delle strategie che i due candidati hanno intenzione di attuare, in caso di elezione, nei settori chiave della politica americana. Possiamo forse prevedere un orientamento molto più multilaterale di Biden, e un nazionalismo, un isolazionismo, un protezionismo ancora più accentuato di Trump in caso di rielezione. Però mi sembrano considerazioni decisamente premature, poiché il mondo che ci lascerà il coronavirus andrà direttamente a bussare al 1600 di Pennsylvania Avenue [ndr. La Casa Bianca] e lì chiederà delle risposte».
Il coronavirus sembrerebbe aver spinto molte persone a sfruttare la possibilità del voto postale. Come si può interpretare questa corsa al voto anticipato? «La leggo in due modi: da un lato bisogna considerare il cosiddetto “effetto Covid”, che ha indotto molti cittadini a ricorrere al voto postale piuttosto che fare lunghe code ai seggi. Non va dall’altro lato sottostimato il peso che i Democratici hanno conferito al voto postale, facendolo diventare un cavallo di battaglia. La strategia messa in atto dal partito dell’asinello mira, attraverso un meccanismo di imitazione e di coinvolgimento, a sollecitare al voto il maggior numero possibile di elettori democratici. Il messaggio lanciato è: “Andiamo a votare prima, facciamo vedere che ci siamo, che ci mobilitiamo, che siamo forti”. In questo modo gli altri sostenitori del partito si sentono galvanizzati e incentivati a cavalcare quest’onda di entusiasmo».
Si può dire dunque che non si vincono più le elezioni al centro, ma smuovendo quelle categorie sociali, non lontane dagli ideali del partito, che però, per ragioni diverse, avevano smesso di votare? «Sì, le elezioni un tempo si vincevano soprattutto al centro, conquistando gli indipendenti; in passato c’era una tendenza a corteggiare quella zona grigia di elettori, i cosiddetti swing voters, per assicurarsi la vittoria. Per certi versi lo si fa ancora adesso, tuttavia da qualche stagione elettorale, mi viene in mente quella del 2004, i partiti, in particolar modo quello Repubblicano, hanno puntato fortemente sulla mobilitazione della base, cercando di portare alle urne gente che aderisce formalmente all’indirizzo del proprio schieramento politico ma che tendenzialmente non si esprime con il voto».
C’è stato qualche caso riuscito nel passato? «Il capolavoro di questo tipo di strategia fu quanto avvenne in Ohio nel 2004, quando Karl Rove, il più lucido degli spin doctor dei candidati alla presidenza degli ultimi 20 anni, approfittò della coincidenza tra il referendum sui matrimoni gay in Ohio e l’election day, per legare la rielezione di Bush al voto contrario alle unioni di fatto. In questo modo si assicurò abilmente l’appoggio di quella fetta di elettorato costituito da evangelici, cattolici e conservatori, che probabilmente sarebbe rimasta a casa, ma che pesò sull’elezione con un esiguo ma fondamentale 2%. Anche nel 2016 i Repubblicani hanno seguito la stessa intuizione per via dell’eccessiva carica divisiva di Trump, che gli avrebbe impedito di conquistare i favori dell’area centrista. Così “The Donald” si è rivolto alla sua base, che seppur in alcuni casi scettica nei suoi confronti, non approderebbe mai sull’altro versante e pertanto, se ben stuzzicata, oggi come allora può eleggerlo presidente».
A proposito di mobilitazione dei vari componenti del tessuto sociale americano, non è forse un po’ pretestuoso classificarli in maniera netta e presumere di ottenerne l’appoggio indiscriminato, dal momento che questi segmenti di popolazione al loro interno sono molto articolati? «È vero. Faccio un’ulteriore riflessione: qual è l’elemento prevalente? L’identità locale (lo stato, la contea in si vive, il background che si ha) o l’identità etnica? Obama, oltre a essere stato il primo presidente afroamericano, è stato anche il primo “nero” a presiedere la prestigiosa rivista di legge dell’università di Harvard. Tra lui e un ragazzo afroamericano nato e cresciuto a Brooklyn o in Alabama c’è un abisso, sono due mondi totalmente diversi. Gli strateghi infatti, quando si rivolgono a tale comunità, non pensano ad Obama, a Colin Powell o a certi personaggi del jet set, ma a tutti quei cittadini di colore che vivono nei sobborghi delle grandi città».
Quindi bisogna bene decidere il proprio target… «La divisione di giudizio vale anche per altri gruppi, pensiamo per esempio al mondo cattolico che, come da noi, perdonami questa distinzione un po’ netta, si differenzia fondamentalmente in due grandi blocchi: coloro che hanno una maggiore sensibilità per i temi sociali e coloro che l’hanno per ambiti più etici; ovviamente le due sfere possono trovare un punto di incontro, tuttavia nel momento in cui devono scegliere chi votare, seguono una gerarchia di valori più vicina a uno dei due candidati. A questo riguardo c’è un esempio molto significativo: alle elezioni del 2004 si fronteggiavano due cristiani, John Kerry e George Bush. Il primo, seppur cattolico, aveva una visione aperta, laica riguardo l’aborto, il secondo più conservatrice. Il mondo cristiano si spaccò: quelli che avevano più a cuore il tema della giustizia sociale, si affidarono a Kerry, mentre i più tradizionalisti a Bush. Questo per dire che lanciare un messaggio agli oltre 60 milioni di cattolici americani che li possa coinvolgere tutti allo stesso modo, è un’impresa pressoché impossibile».
Abbiamo detto che la gestione sanitaria e la pandemia sono state l’anello debole della catena “Trumpiana”. L’economia può essere invece il suo punto di forza? «Se facessimo tornare le lancette dell’orologio a gennaio 2020, le possibilità di rielezione di Trump sarebbero altissime; noi però non possiamo fare filosofia della storia ma dobbiamo anche e soprattutto attenerci alla cronaca, che oggi ci dice che le condizioni economico-sociali degli americani, che come sempre voteranno con la mano sul portafoglio, sono nettamente peggiorate, a causa del Covid, dell’emorragia di posti di lavoro, dell’impossibilità di viaggiare».
A che cosa si sta riferendo? «L’altro giorno la Borsa di Wall Strett ha fatto registrare una pesante perdita, che ha suggellato una settimana di “profondo rosso”. Questo brusco calo della piazza newyorkese non avrà conseguenze soltanto ai piani alti, ma si ripercuoterà, anzi lo sta già facendo, anche sui risparmi dei singoli cittadini. La Borsa, non dimentichiamocelo, è il luogo dove sono contenuti i mitici modelli 401K, i fondi pensione, che rappresentano per gli americani l’unico “salvadanaio” dove poter custodire con parsimonia i propri risparmi, dal momento che negli States non c’è nessuna pensione statale, nessun omologo dell’Inps. Così chi ha investito il suo “tesoretto” in questi fondi, si ritrova ora con un capitale che da 300mila dollari è sceso a poco più di 200mila e allora, dinanzi a queste ingenti perdite, potrebbe trasformare il suo voto in un voto di protesta».
È anche vero che in economia Trump aveva promesso di ricostruire la base industriale americana, combattendo la delocalizzazione, e ci è in parte riuscito. Inoltre il suo protezionismo caratterizzato da dazi, sanzioni e ritiri da accordi commerciali ha fatto scuola, cambiando la direzione della politica economica occidentale. Nel mondo politico non sono più infatti argomenti tabù… «Sono d’accordo. Trump ha avuto un approccio nei confronti della Cina molto risoluto e questo ha permesso alle società americane di guadagnare punti, soldi e business; la sua visione protezionistica ha, inoltre, garantito un certo sviluppo al Paese e l’economia ha corso parecchio fino appunto a gennaio, come non lo faceva dai tempi di Bill Clinton».
E allora, che cosa è cambiato? «I fondamentali dell’economia statunitense sono solidi, migliori probabilmente di quelli che si avevano con i governi precedenti. Però si arriva al voto con un aumento preoccupante dei casi di coronavirus, con i fondi pensione in difficoltà, con un crollo importante dei mercati e con il figlio della signora Smith che ha perso il lavoro. E, per sfortuna del presidente in carica, non si vota pensando a quel che poteva essere, o a quello che potrà essere, bensì pensando a quello che è, a come sto adesso. Arrivati a questo punto non bisogna più convincere solo Wall Street e la “corporate America”, ma gli americani della classe media, che vedono in questo momento storico eroso il loro potere d’acquisto e soprattutto i loro risparmi».
Chiudiamo con un pronostico. Le elezioni possano concludersi serenamente questa notte oppure, tra conteggi, riconteggi, voti postali che arriveranno all’ultimo, contestazioni e la transizione non pacifica minacciata da Trump, c’è il serio rischio che si crei un conflitto istituzionale che chiamerà in causa anche la Corte Suprema? «Dinanzi all’affermazione di Trump, non si può non prefigurare uno scenario caratterizzato da strascichi polemici, da attriti, da un clima rovente. L’America oggi è un Paese che vive sul crinale della tensione, ci sono movimenti a destra e a sinistra che, come hanno ampiamente dimostrato negli ultimi tempi, sono in grado di trasformare una protesta pacifica in una rivolta violenta, in una guerriglia urbana dai connotati politici. Mi auguro, però, che stasera uno dei due candidati, chiunque sia, vinca in modo netto, togliendo fiato a qualsiasi ipotesi o pretesto di ricorso alla Corte Suprema. Se anche non dovesse succedere, credo che l’America abbia gli anticorpi per superare questa possibile fase di incertezza e per arrivare serenamente al 20 gennaio 2021, data del giuramento del nuovo presidente. Ne sono fermamente convinto perché gli Stati Uniti sono una grande democrazia, con degli equilibri saldi e dei contro poteri politici forti».
Ottava di una serie di interviste con giornalisti esperti di politica americana in vista delle Presidenziali Usa 2020