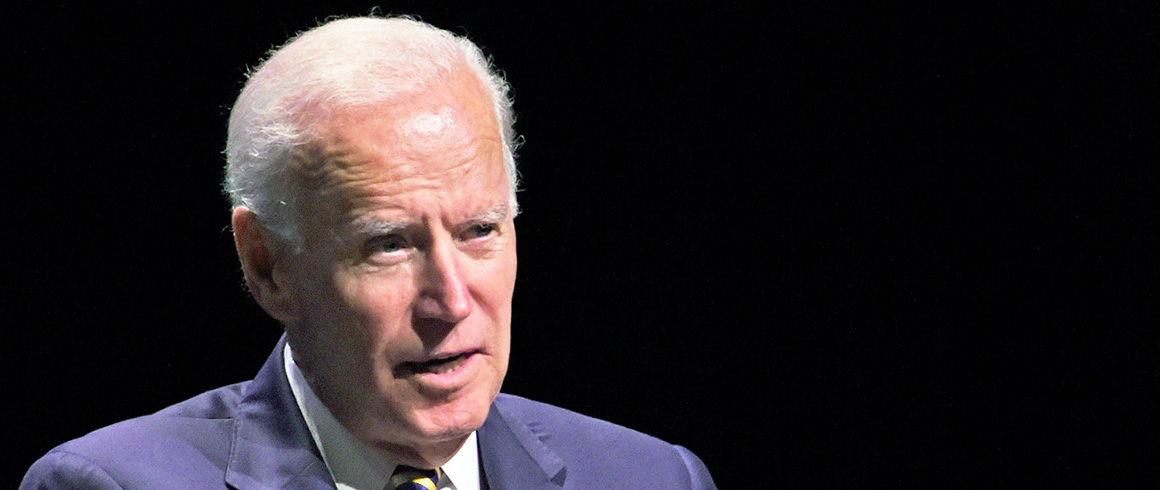Il prossimo 3 novembre gli americani saranno chiamati al voto per le elezioni presidenziali degli Stati Uniti. Abbiamo chiesto ad alcuni giornalisti di varie testate, particolarmente esperti di politica americana e molti dei quali alumni dell’Università Cattolica, di aiutarci a capire dove stanno andando gli Stati Uniti e come affrontano uno dei passaggi più delicati della loro storia. Il nostro speciale
di Giacomo Gitti
«Siamo di fronte alle elezioni forse più polarizzate della storia contemporanea degli Stati Uniti. C’è un grandissimo senso di appartenenza fra gli elettori, che sta trasformando il confronto tra i due leader in una battaglia all’ultimo sangue senza esclusione di colpi e il voto in una questione ideologica». Paola Peduzzi, diplomata al master di Giornalismo dell’Università Cattolica, si occupa da anni di politica a stelle e strisce. Lo fa dalle colonne de “Il Foglio”, di cui oltre che vicedirettrice è una delle penne più fini della redazione “Esteri”.
«La polarizzazione dello scenario politico è stata animata e incoraggiata da Trump, che fin dal principio ha imposto la sua idea di politica caratterizzata da spaccatura, litigiosità e da quel clima di microconflittualità che ha contraddistinto ogni disputa. Per lui fare politica vuol dire separare “i suoi dagli altri”, aggredire ferocemente i nemici e proteggere la sua squadra a ogni costo, alle volte in maniera poco coerente».
Parliamo di un caso concreto… «La pandemia è stata esemplare: invece che cercare l’unità del Paese, ha cominciato a fare distinzioni tra Stati, tra governatori democratici e repubblicani, mettendoli quasi in competizione sulla gestione del Covid e sull’approvvigionamento dei materiali sanitari necessari. Questa sua volontà spiega il momento di enorme ebollizione in cui si trovano gli Stati Uniti».
Le proteste e la crisi sociale che si è innescata sono la fotografia di questa situazione incandescente che si è venuta a creare. L’aggressività di Trump ha contribuito a surriscaldare gli animi? «Sì, proteste e crisi sociale sono la conseguenza più tragica e visibile, anche perché ci sono di mezzo questioni importanti, come i diritti delle persone e la sicurezza nazionale, che sono temi molto cari a tutti gli elettori. Anche in questo caso la strategia di Trump è stata quella di assimilare le proteste con l’estremismo (“sono tutti Antifa, anarchici…”), perché una volta che le hai etichettate in quel modo è più facile colpirle e insieme distogliere l’attenzione dal nocciolo della questione, cioè la riforma del sistema di polizia».
È un’evidente semplificazione… «Certo, non sono tutti violenti e nessuno può essere contro il desiderio di sicurezza e lui lo sa benissimo, però, in questo modo, è riuscito a strutturare il dibattito a suo piacimento, identificando il nemico, creando lo slogan e soprattutto rilanciando la palla nel campo dell’avversario, che poi la gioca come può. Questa strategia rischia di crollare dal momento che non ha creato l’unità, non ha curato la pandemia, le divisioni ci sono ancora e le proteste continuano. Il presidente degli Stati Uniti dovrebbe avrebbe avere come primo obiettivo quello di lenire le ferite, curarle, cercare unità, compromessi, dialogo, mentre Trump fa l’esatto contrario; se questo atteggiamento possa giovargli lo vedremo il 3 novembre, che sia un disastro per l’America mi sembra già evidente».
A proposito di “Black Lives Matter”, quanto può pesare l’appoggio dell’elettorato afroamericano a Biden nel computo finale? La scelta della Harris sembra eloquente in tal senso… «Kamala Harris è l’unica vera grande novità di questa campagna elettorale, l’unica storia da raccontare, perché rappresenta un mondo, una visione, una presenza realmente innovativa, promettente rispetto al futuro. Penso che abbia delle idee talmente chiare, dei principi talmente saldi in testa da poter indicare la via da seguire a un partito che, come molte sinistre occidentali, ha bisogno di una direzione. Era comunque abbastanza scontato per la stagione che viviamo che Biden scegliesse una donna di colore e, forse, questa inevitabilità ha tolto un po’ di quella carica che Kamala ha e pure in grande abbondanza. Così doveva andare e poi è risaputo che la politica non si fa solo con grandi statement, belle pubblicità, ma anche e soprattutto con determinati calcoli elettorali: il voto afroamericano, che tra le altre cose ha permesso a Biden di trionfare su Sanders nelle primarie, non è giunto in soccorso della Clinton nel 2016 e oggi può servire a rompere quell’apparente equilibrio pronosticato dai sondaggi».
Quindi possiamo dire che “Black vote matters”? «L’elettorato afroamericano pesa, a maggior ragione negli Stati in bilico e in quegli Stati che la Clinton perse in maniera sciagurata nel 2016. Ci sono ovviamente tanti altri voti che contano, come quelli dei giovani che quattro anni fa non si erano recati alle urne. Sul tentativo di mobilitazione di questi due segmenti di popolazione si basa la campagna di Biden, che è fondamentalmente riassumibile con uno slogan (anche perché non ce ne ricordiamo molti altri): “Se volete cambiare lo scenario attuale, l’unica cosa che potete fare è votare”».
La Harris ha destato un’ottima impressione anche nel dibattito con il suo omologo Mike Pence, rispetto al flop tra i due leader… «Non penso che i dibattiti televisivi influenzino così tanto gli elettori, sono più un divertimento per le persone appassionate di politica. A maggior ragione quest’anno dove, nella campagna più polarizzata che io ricordi, sono in molti ad aver già preso una decisione. Inoltre in queste elezioni si fronteggiano due candidati tutt’altro che sconosciuti: Trump è il presidente uscente, con quattro anni di governo alle spalle da giudicare, mentre Biden è da quarant’anni in politica ed è stato pure il vice di Obama...».
Quindi, televisivamente parlando, Harris-Pence batte Trump-Biden? «Il dibattito tra i due vicepresidenti è stato sicuramente più decoroso del primo tra i leader, dove invece si è rasentato il grottesco. La cosa tuttavia non mi ha sorpreso: Trump ormai lo conosciamo, mi aspettavo i suoi attacchi, i suoi slogan ripetuti fino allo sfinimento ma Biden non è riuscito a elevare il livello della discussione, adeguandosi al clima rovente generato artificiosamente dal suo sfidante».
L’alto livello di polarizzazione è riuscito a smorzare le polemiche divampate dai diversi scandali che hanno riguardato Trump, ma anche Biden. Perché? «Il “Trumpismo”, come abbiamo imparato a capire, è un fenomeno inossidabile, quasi inscalfibile. Qualsiasi accusa che avrebbe ucciso ogni genere di leadership, con “The Donald” non sembrava avere alcun effetto. Hai un presidente, la figura in cui la gente dovrebbe immedesimarsi, che ha pagato in un anno 750 euro di tasse. È talmente comica la vicenda che viene da pensare che forse gli americani scelgano il loro presidente con criteri diversi da quelli a cui noi siamo abituati. Oppure siamo solo noi giornalisti, visti gli errori di quattro anni fa, troppo impauriti per dirlo: potrebbe davvero essere rimasta solamente una ridotta ala “Trumpiana” a bollare queste accuse di complottismo, mentre la stragrande maggioranza del Paese avrebbe le idee piuttosto chiare e sarebbe pronta a voltare pagina. Lo scopriremo il 3 novembre».
Eppure Trump tira dritto per la sua strada… «L’aspetto più interessante emerso da quest’inchiesta è un altro e smonta completamente l’immagine di “presidente del popolo”, avulso da qualsiasi logica lobbistica, che Trump ha provato a cucirsi addosso per ingraziarsi i cittadini americani, stanchi, a suo dire, delle ingerenze nella politica statunitense dei gruppi di pressione. Utilizzando una sua metafora, si potrebbe dire, dopo quest’inchiesta, che il presidente che avrebbe dovuto “prosciugare la palude” se n’è costruita un’altra, più confacente alle sue caratteristiche, in cui i punti di partenza, di smistamento dei privilegi sono i suoi alberghi, i suoi resort, in soldoni la Trump Organisation. L’attuale presidente non ha messo fine alla cultura dei favoritismi, parte consistente della “palude”, non ha cambiato il sistema, l’ha semplicemente riadattato a nuove priorità, a nuovi amici, a nuovi privilegi. E questo discorso vale, ahinoi, anche per tanti altri leader populisti…».
Una questione che ci interessa più da vicino è la politica estera. In caso di sconfitta di Trump, potrebbero cambiare le cose? «Sì, perché l’America in questi quattro anni non è stata più percepita come l’alleanza affidabile per eccellenza, ruolo che, invece, ha sempre assunto. Trump, che prova disprezzo per tutto ciò che è multilaterale, per tutte le decisioni collettive, ha stroncato volontariamente questa fiducia, che dal dopoguerra in avanti è rappresentata dalle istituzioni internazionali e da tutte le loro declinazioni. Una svolta democratica teoricamente farebbe pensare a un ritorno di questa fiducia, di questa collaborazione con alcuni storici alleati».
Anche se pure in passato la politica estera americana non ha brillato per linearità… «Analizzando nel dettaglio i singoli dossier le cose sono, infatti, più sfumate: credo che Biden porterà avanti questa nuova “Guerra Fredda” con la Cina e anche in Medioriente non credo ci saranno grossi scossoni, anche perché l’accordo tra Israele e il mondo arabo ha una portata storica; l’ex vice di Obama magari cercherà altri equilibri, per esempio in Iran dove difficilmente avrà lo stesso atteggiamento del suo predecessore, in virtù anche di quegli Accordi sul Nucleare fortemente voluti dal governo Obama, aboliti recentemente da Trump».
E sull’Europa? «Il Vecchio continente si sentirebbe sicuramente rassicurato dall’arrivo di Biden, anche se già con Obama era iniziata questa fase di progressivo disinteresse statunitense verso alcune questioni europee, come la guerra in Libia e più in generale la gestione del Mediterraneo. Non dimentichiamoci che fu proprio Obama il primo a chiedere agli alleati di fare di più, appellandosi alla necessità di riequilibrare l’impegno americano nel mondo (“non voglio free riders”). Poi Trump ha esasperato questo approccio, costringendo i Paesi europei a ragionare più in maniera autonoma e spingendo di conseguenza l’Ue a diventare un player, quasi una superpotenza, in grado di ricoprire una posizione centrale nello scacchiere internazionale. Quello che fanno i genitori con i figli che crescono a vista d’occhio».
Terza di una serie di interviste con giornalisti esperti di politica americana in vista delle Presidenziali Usa 2020