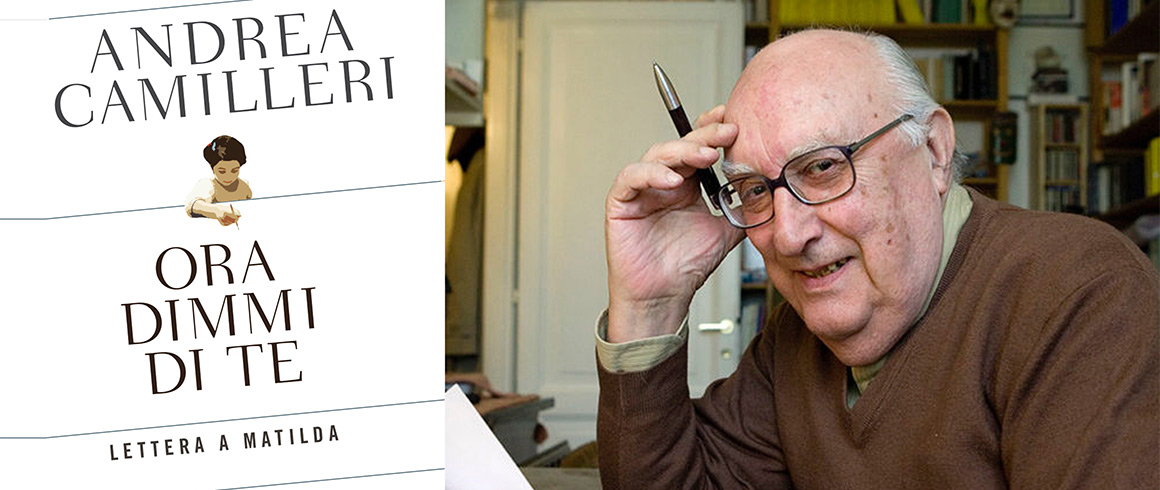di Giuseppe Lupo *
Ho incontrato Andrea Camilleri due volte, quando gli era stato attribuito il Premio Campiello alla carriera, nel 2011, e quattro anni più tardi, nel 2015, quando la Casa del Manzoni, a Milano, lo aveva invitato per un dialogo a posteriori con l’illustre inquilino di via del Morone.
In entrambe le circostanze Camilleri era celebrato come maestro, anche se non lo faceva pesare, anzi se ne schermiva, ricorrendo a quel suo cifrario dialettale che lo dichiarava geograficamente appartato. Camilleri non abitava una regione con un preciso orizzonte spazio-temporale, ma una lingua, la sua, che aveva regole a cui piano piano i lettori si erano abituati, accettando termini su cui in altri casi avrebbero sorvolato per fretta, per incompetenza, per avversione verso gli idiomi troppo caratterizzati.
Questo è stato il più grande paradosso della narrativa di Camilleri: più la scrittura andava a circoscriversi nei particolarismi, più diventava popolare. La regola è illogica e paradossale, ma è la conferma di una irregolarità di cui ogni tanto il mercato abbisogna. Seduto a un tavolino da caffè sulla laguna veneziana, Camilleri si godeva il successo che il Teatro La Fenice poco dopo gli avrebbe tributato, ma parlava poco, sorrideva e ascoltava, osservando l’oscillare delle gondole.
A Milano invece aveva già problemi di vista e le parole che scambiai con lui, nel pochissimo tempo a disposizione, erano legate ai meccanismi della memoria: ricordo, non mi ricordo…
In mezzo ai due incontri era stato pubblicato un suo libro, Dentro il labirinto, a cui mi ero subito legato e che recensii con entusiasmo. Camilleri si era cimentato con un personaggio enigmatico e affascinante come Edoardo Persico: un napoletano laureato in giurisprudenza, morto a soli trentasei anni, che era stato tra i protagonisti della Milano astrattista e razionalista negli anni Trenta. Persico non era solo un intellettuale, ma un crocevia culturale e Camilleri si era avventurato fra le numerose domande che la sua vita aveva lasciato irrisolte, cercando di mettere ordine, come un giallista sa fare, negli indizi, nelle supposizioni, nelle prove. Alla fine di un lungo rompicapo si era dovuto arrendere: Persico continuava a non volersi svelare nemmeno a lui, che era uno dei più abili costruttori di ragnatele narrative.
Qualcosa di quest’uomo restava nelle ombre del non detto e riguardava la sua morte - naturale o provocata? - che in un modo o nell’altro finiva per riverberare sulla vita. Un aspetto mi sorprendeva di quel libro e finiva per essere, quello sì, una grande testimonianza di arte narrativa. Dei dodici capitoli, nei primi nove Camilleri raccoglieva ed elencava prove, narrava i fatti veri obbedendo ai cardini delle regole retoriche che Cicerone aveva fissato nel De inventione: l’inventio e la dispositio. Negli ultimi tre dichiarava di non avere più piste per proseguire nelle sue indagini, smetteva i panni del commissario e assumeva l’abito del facitore di storie: tre capitoli racchiudevano tre differenti supposizioni sulla morte di Persico e dunque, a ritroso, anche sulla sua esistenza e sul suo lavoro.
Erano un manifesto narrativo: là dove non arrivano i documenti, bisogna proseguire affidandosi alle ipotesi, disegnare un orizzonte che nessuna fonte autorizza ma che tuttavia potrebbe essere altamente probabile. Camilleri dimostrava di essere andato alla scuola di Manzoni: la formula che Manzoni usa per il genere del romanzo storico, il “componimento misto di storia e invenzione”, era stata rispettata in tutte le sue parti. Camilleri aveva diritto di abitare nella casa di Don Lisander.
* docente di Letteratura italiana moderna e contemporanea della facoltà di Lettere e filosofia